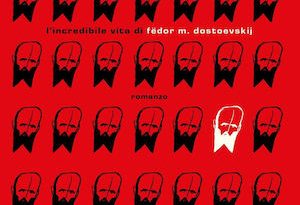Gli ultimi ragazzi del secolo – Alessandro Bertante
Ho avuto la fortuna di leggere Via Ripetta di Clara Sereni prima di accostarmi a quest’ultima fatica letteraria di Alessandro Bertante, arrivato con Gli ultimi ragazzi del secolo (Giunti, 2016) al suo quinto romanzo. Lo dico perché, lungi dal voler portare avanti una qualsivoglia comparazione tra i due libri, la lettura di Via Ripetta in qualche modo “ridimensiona” alcune delle pagine che ci vengono proposte da Bertante.
Lui, con una prosa che corre e che sgroppa come un cavallo selvatico, tra improvvisi scarti temporali, incursioni nel parlato e lampi di ispiratissima tensione narrativa, mette a nudo la propria infanzia e adolescenza di ragazzo degli anni ’80, alternando il racconto delle sue esperienze in una Milano a stento riconoscibile a quello del suo viaggio nei Balcani a bordo di una Panda scassata in compagnia del silenzioso amico Davide. Più scassata – anzi squassata – della Panda è la Jugoslavia, irriconoscibile dopo i massacri, i bombardamenti e le morti che ne hanno irrimediabilmente cambiato il volto.
La narrazione è in prima persona, e non tace niente, anzi alle volte esagera. Il rischio, di queste rievocazioni autobiografiche riferite a un tempo per forza di cose già superato, è di incorrere nell’umanissima tendenza a trasfigurare le cose: non come ci sentivamo, ma come alla nostra mentalità di adesso sembra che ci sentissimo; non come ci vedevamo, ma come i nostri occhi di adesso ci visualizzano, e cioè avvolti di un’affascinantissima patina di eroismo, da “belli e dannati”.
Bertante parla del boom economico, parla di Tangentopoli, parla della nascita e dell’espansione delle tv di massa, parla della musica, di suicidi adolescenziali e dell’eroina diffusa nel Paese come una malattia senza scampo. Parla di una Milano periferica, pericolosa, ambigua, fangosa, piena di attivisti, irregolari, spacciatori, frequentatori dei centri sociali. E a dirla tutta i posti di cui parla sembrano distorti dalla voce allucinata e vaticinante di uno strano oracolo che anziché predire il futuro dà vita al passato, ma deformandolo, come si fa con una materia fluida osservata attraverso un vetro affumicato.
Bonola, Lotto, Amendola, Qt8, il Leoncavallo, il Liceo Beccaria… tappe di un universo alla Blade Runner nel quale si guardava la morte in faccia ogni giorno. Che dire, io a Qt8 prendevo il pullman per tornare a casa dal liceo e guardavo sconosciuti bambini uscire dall’asilo, durante la lettura provo un certo senso di spaesamento.
Forse gli anni ’80 sono quelli che conosciamo di meno, perché sono quelli di cui, per un motivo o per l’altro, si parla di meno.
Eravamo i giovani di Milano Metropoli degli anni Ottanta ma della nostra gioventù non sapevamo che farcene, cresciuti nell’erosione della capitale morale, senza memoria, senza maestri, braccati dall’eroina.
Bene, nel ’68 la Sereni e la Storia ci insegnano che si accoglievano in casa i rifugiati politici, si crepava di fame in appartamenti gelidi nel cuore di Roma, si raccoglievano fondi “vendendo anellini fatti con il metallo dei B-52 abbatutti dai vietcong”. Negli anni Settanta a Milano ci si sparava direttamente per le strade. Venivano gambizzati professori universitari mentre facevi lezione nell’aula accanto. Si andava in manifestazione coi passamontagna. A tacere di BR, fascisti, attentati, terroristi di destra e di sinistra.
Questo per dire che ogni generazione ha i suoi motivi per ricordare la propria gioventù come la più ardua. La più amara. La più pericolosa. La più formativa. Ognuno si rivede e si sente come un sopravvissuto.
Belle pagine regalano al lettore immagini inedite di Sarajevo, della sua gente, delle sue attrattive urbanistiche e naturali, dei suoi sapori e colori, evocati con penetrazione e spirito di osservazione tra un coprifuoco e l’altro. Sono i passaggi più intimistici e lirici del libro, quelli in cui per qualche attimo possiamo condividere con l’autore interrogativi profondi, esistenziali, dopo sequenze e sequenze allucinate e allucinogene sulle avventure metropolitane di una creatura squisitamente letteraria.
Se si riesce a emergere dal clima apocalittico di giovani e bellissimi eroinomani che muoiono come pallidi fiori malati si incontrano brani di grande forza, di autentica ispirazione, di netto valore estetico, come questo:
La prima volta che ascoltai i Joy Division rimasi folgorato. Questo è il mio tempo pensai, l’unico che mi riguardi. Era una musica struggente, di spietata franchezza, poggiata su ritmi monotoni e sincopati. Una musica oscura, essenziale ma tremante di emozione. Finalmente mi confrontavo con qualcosa di autentico, nato nel ventre delle metropoli abbandonate a se stesse. Sentivo delle vibrazioni eterne in quelle note liminari, non bastava fare girare il disco sul piatto, bisognava affrontarlo in un corpo a corpo emotivo che lasciava sempre delle ferite e talvolta aveva perfino la forza di curarle. I Joy Division erano l’ulcera profonda degli anni Ottanta, la sublimazione estetica della crisi, nata dalla consapevolezza di vivere in un’epoca disperata. Furono l’ariete che stavo cercando, il maglio che mi spalancò le porte di un mondo sconosciuto fatto di voci cavernose, testi strazianti, suoni industriali, simbolismi decadenti, fascinazioni ossianiche, tribalismo, amori vissuti ai margini, migliaia di solitudini senza conforto. In poco tempo conobbi decine di gruppi underground, alfieri di una musica perversa e melanconica che, infranta l’irritante superficie gotica, nascondevano un’impronta marziale integerrima, un disperato romanticismo capace di urlare la ferma negazione di ogni asservimento al presente. Gruppi formati da ragazzi giovanissimi che registravano dischi proprio in quel momento: sgraziati, privi di tecnica, ispirati, lontani da ogni virtuosismo ma con l’urgenza di comunicare la propria distinzione.
Bello! Bertante, ora ti vogliamo in un libro sulla musica!
Gli ultimi ragazzi del secolo
Alessandro Bertante
Giunti, 2016
Pagine 224
Prezzo di copertina € 16,00